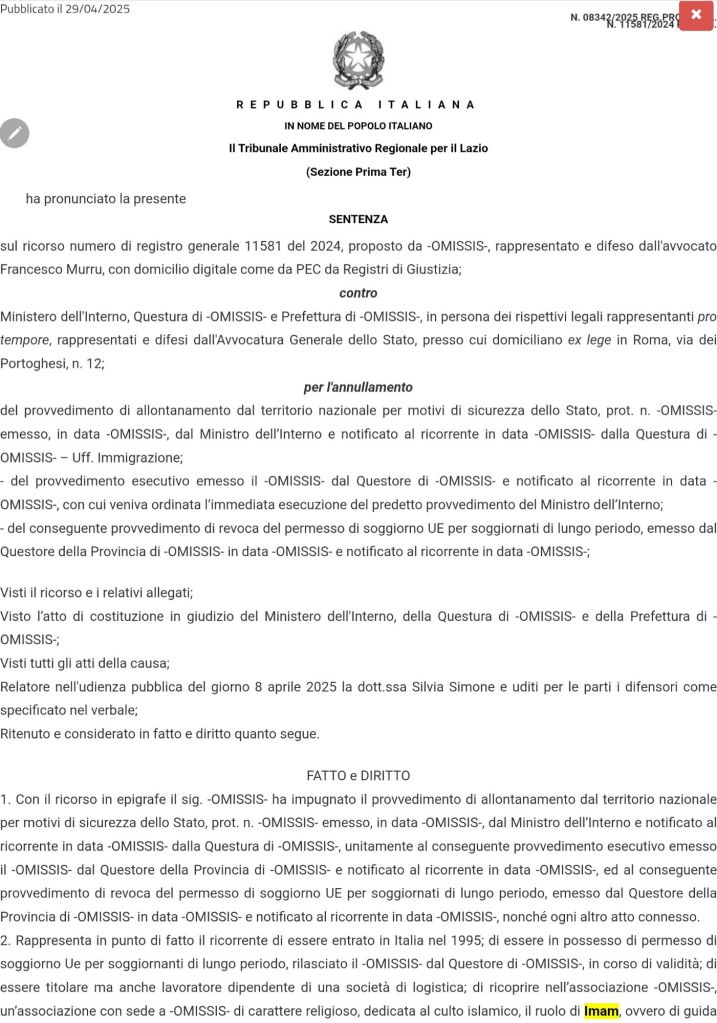
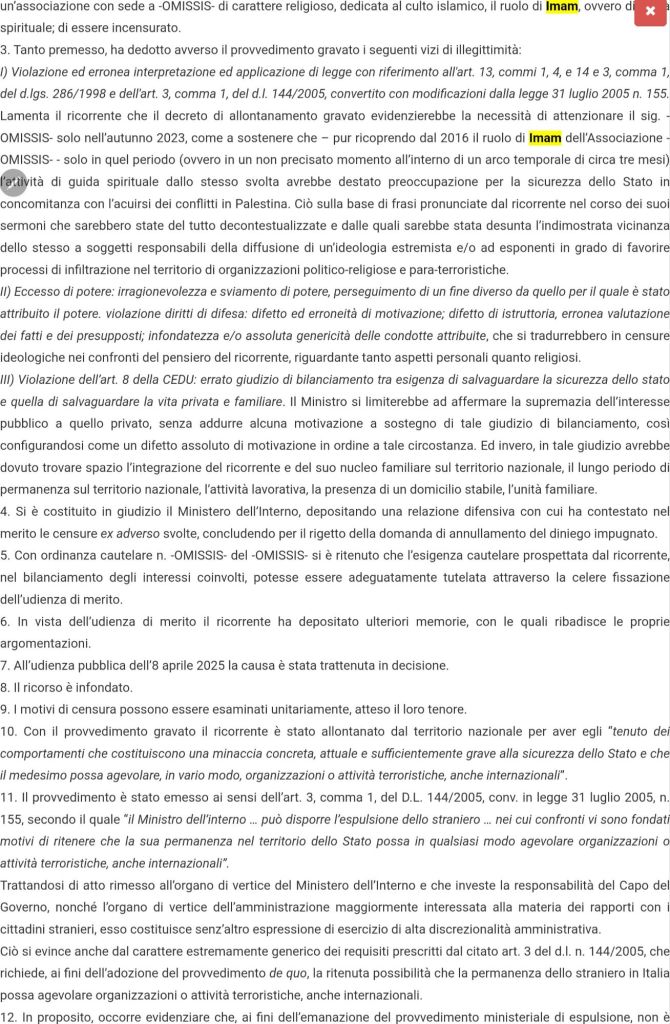

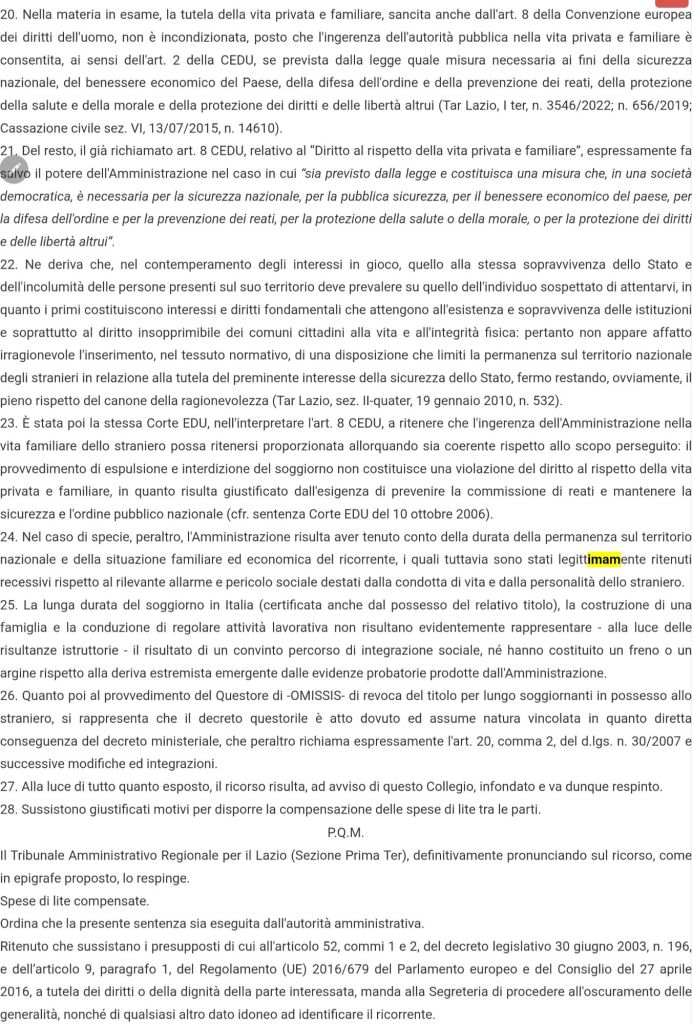
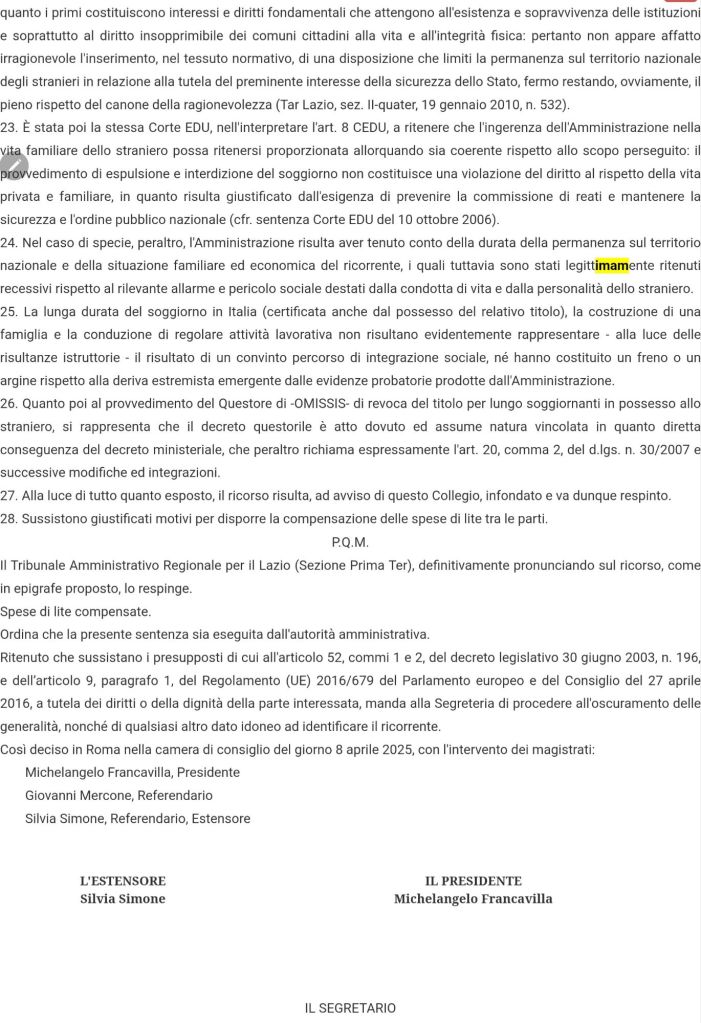
La giurisprudenza amministrativa continua a ricordare, con una chiarezza che spesso manca nel dibattito pubblico, che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non è un diritto incondizionato, ma il risultato di un equilibrio delicato tra interessi individuali e beni collettivi primari.
La sentenza del TAR Lazio del 2025, intervenuta su un provvedimento di espulsione ministeriale per motivi di sicurezza dello Stato, rappresenta uno snodo particolarmente significativo in questa direzione, perché mette a fuoco il punto in cui l’integrazione, se solo apparente, cessa di poter fungere da argine all’esercizio del potere di allontanamento.
Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo riguarda un cittadino straniero presente in Italia da molti anni, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inserito formalmente nel tessuto sociale e lavorativo e con un ruolo di guida religiosa all’interno di un’associazione di culto islamico. Proprio questo dato, apparentemente neutro o addirittura positivo, viene assunto dal ricorrente come elemento centrale a sostegno della pretesa illegittimità dell’espulsione: lunga permanenza, famiglia, lavoro e attività religiosa come prova di integrazione e, dunque, come limite invalicabile all’intervento dello Stato.
Il TAR Lazio respinge con decisione questa impostazione, chiarendo che l’integrazione non può essere ridotta a un dato meramente quantitativo o formale. Anni di soggiorno regolare, un titolo di lungo periodo o la conduzione di una vita familiare non sono, di per sé, indici sufficienti di adesione sostanziale ai valori fondanti dell’ordinamento. Quando le risultanze istruttorie evidenziano una radicale avversione ai principi democratici, la diffusione di un’ideologia incompatibile con la convivenza civile o la capacità di influenzare altri soggetti in senso destabilizzante, l’integrazione si rivela per ciò che è: apparente.
La sentenza assume rilievo soprattutto per il modo in cui delimita il rapporto tra piano penale e piano amministrativo. Il Collegio ribadisce che l’espulsione disposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge 155/2005, non ha natura sanzionatoria, ma preventiva. Non è richiesta la prova di una responsabilità penale accertata né la commissione di un reato, essendo sufficiente la sussistenza di “fondati motivi” per ritenere che la permanenza dello straniero possa agevolare, anche indirettamente, organizzazioni o attività terroristiche. Lo standard valutativo si colloca, dunque, sul terreno del giudizio prognostico di pericolosità sociale, secondo il criterio del “più probabile che non”, radicalmente diverso da quello penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In questo quadro, il potere esercitato dal Ministro dell’Interno viene qualificato come espressione di alta discrezionalità amministrativa, strettamente connessa alla responsabilità politica per la tutela della sicurezza nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio dell’autorità di vertice, ma resta circoscritto alla verifica dell’assenza di vizi macroscopici: illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria. Nel caso esaminato, il TAR ritiene che l’amministrazione abbia fondato il proprio convincimento su un insieme coerente di elementi, valorizzando condotte, prese di posizione pubbliche, contenuti diffusi attraverso strumenti informatici e una rete di relazioni idonee a sostenere un giudizio di pericolo concreto e attuale.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato al bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 della CEDU. Il TAR Lazio richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per ribadire che tale diritto non è assoluto. L’ingerenza dell’autorità pubblica è legittima quando sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo e risulti necessaria in una società democratica per la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. In questo bilanciamento, l’interesse alla sopravvivenza dello Stato e alla protezione dell’incolumità dei cittadini assume un peso prevalente rispetto all’interesse individuale alla permanenza, soprattutto quando quest’ultimo si fonda su un’integrazione solo formale.
È in questo snodo che la decisione si presta a essere letta come una conferma giuridica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La ReImmigrazione, così intesa, non è una misura punitiva né una scorciatoia ideologica, ma uno strumento di difesa costituzionale. Essa interviene quando viene meno il presupposto stesso dell’integrazione, ossia l’adesione sostanziale ai valori e alle regole della comunità ospitante. Non si colpisce la fede religiosa in quanto tale, ma l’uso della religione come veicolo di rottura del patto civile e come fattore di destabilizzazione dell’ordine democratico.
La sentenza del TAR Lazio mostra come l’ordinamento italiano disponga già oggi degli strumenti per interrompere un percorso di permanenza che si rivela incompatibile con la sicurezza collettiva. Mostra anche che continuare a rappresentare l’integrazione come un processo irreversibile e sempre prevalente significa ignorare la struttura stessa del diritto pubblico, che assegna allo Stato il compito primario di tutelare la propria sicurezza e quella dei cittadini.
In definitiva, la pronuncia afferma un principio che merita di essere detto con chiarezza: la sicurezza nazionale viene prima dell’integrazione apparente. Quando l’integrazione si rivela una finzione, priva di adesione reale ai valori costituzionali, la ReImmigrazione non è un fallimento dello Stato, ma l’esercizio responsabile della sua funzione di difesa.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

- When Integration Becomes a Legal StandardArticoli
- Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgehtIn Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
- Article 18-ter of the Italian Draft Law Implementing the EU Migration Pact: Automatic Status After Five Years or Real Integration?Articoli
- Integration or ReImmigration: A New Paradigm Beyond Economic ReductionismArticoli
- Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal AudienceIn 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
- Quand l’intégration devient une règle juridiqueArticoli
- Intégration ou ReImmigrazione : quand le droit décide qui reste et qui retourneArticoli
- Intégration ou ReImmigrazione : pourquoi le débat européen dépasse la seule question économiqueEn Europe, l’Espagne est aujourd’hui souvent présentée comme un modèle pragmatique de gestion migratoire. Plusieurs analyses italiennes l’ont récemment souligné, notamment l’article « L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo » publié par 7Grammilavoro (https://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/) et « Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione » publié par Il Bo Live – Université de Padoue… Leggi tutto: Intégration ou ReImmigrazione : pourquoi le débat européen dépasse la seule question économique
- L’articolo 18-ter dello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e asilo”: automatismo quinquennale o verifica sostanziale dell’integrazione? Un raffronto con il sistema vigente ex articolo 19 del Testo Unico ImmigrazioneArticoli
- Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europeaEn 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
- Cuando la integración se convierte en condición jurídicaArticoli
- Integration oder ReImmigrazione: wenn das Recht entscheidet, wer bleibt und wer zurückkehrtArticoli
- Integration or ReImmigrazione: Why Europe’s Immigration Debate Is Not Just About LaborIn recent European discussions, Spain is often presented as a pragmatic and forward-looking model of immigration management. Two recent Italian publications illustrate this narrative clearly. The first, “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, published by 7Grammilavoro (https://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/), argues that regular migration can function as a lever for economic development. The second,… Leggi tutto: Integration or ReImmigrazione: Why Europe’s Immigration Debate Is Not Just About Labor
- Artikel 18-ter des italienischen Gesetzentwurfs zur Umsetzung des EU-Migrations- und Asylpakts: Automatischer Schutz nach fünf Jahren oder echte Integrationsprüfung?Articoli
- Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen KontextIm Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
- When Integration Becomes LawArticoli
- Integración o ReImmigrazione: cuando el derecho decide quién permanece y quién regresaArticoli
- Senza verifica non c’è integrazione: oltre l’esempio spagnoloNel dibattito europeo sulle politiche migratorie la Spagna viene spesso indicata come laboratorio di un modello più inclusivo. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su Il Bo Live – Università di Padova dal titolo “Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione”, consultabile al seguente link:https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione L’articolo descrive la scelta politica spagnola di ampliare i canali di… Leggi tutto: Senza verifica non c’è integrazione: oltre l’esempio spagnolo
- L’article 18-ter du projet de loi italien d’application du Pacte européen sur la migration et l’asile : automatisme après cinq ans ou véritable intégration ?Articoli
- Formation juridique continue sur la protection complémentaire : une perspective italienne ouverte au débat françaisEn 2026, j’organise à Bologne un cycle structuré de formations juridiques accréditées par le Conseil de l’Ordre des Avocats de Bologne au titre de la formation continue obligatoire, avec l’attribution de deux crédits de formation pour chacun des événements, conformément à la communication officielle de la Commission compétente. Ces séminaires s’inscrivent dans le cadre du… Leggi tutto: Formation juridique continue sur la protection complémentaire : une perspective italienne ouverte au débat français
- La protezione complementare diventa struttura del sistemaArticoli
- La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata immigrazione, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026: protezione complementare e paradigma “Integrazione e ReImmigrazione”La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026, si colloca in un momento di particolare tensione sistematica per la protezione complementare… Leggi tutto: La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata immigrazione, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026: protezione complementare e paradigma “Integrazione e ReImmigrazione”
- Integration or ReImmigrazione: how the law decides who stays and who returnsArticoli
- Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economicaNel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
- Article 18-ter of Italy’s Draft Law Implementing the EU Migration and Asylum Pact: Five-Year Automatic Status or Genuine Integration Test?Articoli
- Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal AudienceIn 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
Lascia un commento