La proposta di legge presentata dai deputati Morrone, Molinari, Andreuzza, Bisa e Maccanti rappresenta uno dei tentativi più organici degli ultimi anni di rivedere la disciplina della cittadinanza e del ricongiungimento familiare.
Il provvedimento interviene in un contesto politico segnato dal referendum dell’8-9 giugno 2025, che ha confermato l’orientamento prevalente dell’opinione pubblica: la cittadinanza non può essere un riconoscimento automatico né un esito meccanico della permanenza, ma deve essere attribuita con criteri più selettivi, capaci di garantire la coesione e la sicurezza della comunità nazionale.
La proposta A.C. 2613 recepisce questa sensibilità, inasprendo i requisiti, ridisegnando le preclusioni, introducendo un esame di integrazione e accelerando i tempi procedimentali.
È una riforma che si presenta come rigorosa, orientata all’ordine e alla chiarezza, e che certamente segna una discontinuità rispetto all’impostazione degli ultimi quindici anni.
Tuttavia, alla prova di una lettura sistematica, il suo impianto rimane ancorato a un modello tradizionale, incentrato su criteri quantitativi (anni di residenza, requisiti reddituali, assenza di condanne), senza compiere quel passo ulteriore che trasformerebbe l’integrazione in un vero fondamento giuridico del sistema.
Il cuore innovativo della riforma è rappresentato dall’introduzione di un esame di integrazione per l’acquisto della cittadinanza.
Sul piano simbolico e culturale, si tratta di un avanzamento importante: riconosce che la cittadinanza non è soltanto una somma di requisiti amministrativi, ma implica la conoscenza delle regole minime di convivenza e dei valori fondamentali dell’ordinamento.
L’esame segna il passaggio da una logica dichiarativa a una logica valutativa. Resta però un elemento isolato, non inserito in un quadro normativo che definisca l’integrazione come un percorso unitario, misurabile, con conseguenze giuridiche chiare.
La riforma affida all’esame un ruolo quasi simbolico, mentre non introduce strumenti strutturali per verificare l’integrazione lungo l’intero percorso dello straniero.
Lo stesso vale per le nuove preclusioni penali e per il rafforzamento degli istituti di revoca. L’intento di garantire l’ordine pubblico è legittimo, e la previsione di casi più ampi di revoca risponde a una domanda sociale precisa. Tuttavia, anche qui manca un modello che colleghi in modo sistematico il rispetto delle regole al godimento dei diritti più intensi.
Le norme definiscono ciò che impedisce o fa perdere la cittadinanza, ma non disciplinano ciò che costruisce, conserva e sviluppa l’integrazione.
L’ordinamento continua a muoversi nella logica del “se sbagli, perdi”, non in quella del “se ti integri, cresci e accedi”.
L’aspetto forse più rilevante sotto questo profilo riguarda il ricongiungimento familiare. Le soglie reddituali più elevate e l’obbligo assicurativo generalizzato rappresentano un irrigidimento evidente, volto a garantire la sostenibilità economica dell’ingresso dei familiari. Tuttavia, anche qui la riforma non introduce un parametro qualitativo di integrazione.
Non dice mai che il ricongiungimento è subordinato alla partecipazione sociale, alla conoscenza della lingua da parte del richiedente, alla dimostrazione di un reale percorso di inserimento nel tessuto comunitario. Il ricongiungimento rimane un istituto misurato sul reddito, non sulla capacità della persona di vivere stabilmente secondo i valori del Paese ospitante.
L’effetto complessivo è quello di una riforma che rafforza i filtri, ma non costruisce un paradigma. Eppure proprio questo sarebbe il salto necessario per superare un sistema che, da oltre vent’anni, affronta l’immigrazione attraverso strumenti parziali, spesso emergenziali, a volte contraddittori.
L’integrazione rimane evocata, mai definita. Appare nei testi preparatori, ma non diventa criterio giuridico.
L’Italia continua così a non dotarsi di una nozione normativa di integrazione, nonostante la sua centralità nel dibattito pubblico e nella giurisprudenza.
La proposta A.C. 2613 compie certamente un passo in avanti: rende più responsabile la cittadinanza, più selettivo il ricongiungimento, più rapido il procedimento amministrativo.
Ma non affronta il nodo strutturale del sistema: la mancanza di un modello positivo, non solo repressivo, che definisca l’integrazione come obbligo e come percorso.
Il legislatore rinuncia a introdurre parametri continui di verifica, meccanismi di valutazione periodica, o un quadro normativo che colleghi esplicitamente l’accesso ai diritti più intensi alla realizzazione di un progetto di vita coerente con la comunità nazionale.
In altre parole, la riforma rafforza il rigore ma non costruisce la direzione. Rende più difficile entrare e più facile revocare, ma non stabilisce come e quando uno straniero diventa effettivamente parte della società. Manca il principio che dovrebbe sorreggere una legislazione moderna: l’integrazione non come slogan, ma come architrave dell’intero sistema.
Finché questo passaggio non verrà compiuto, la disciplina dell’immigrazione continuerà a oscillare tra aperture episodiche e chiusure improvvise, senza un fondamento stabile e riconoscibile.
La vera domanda politica è dunque un’altra: l’Italia vuole un modello di immigrazione basato sulla residenza o sulle regole? Vuole misurare il tempo o la qualità della presenza? Vuole limitarsi a contenere gli effetti o intende governare i processi?
La proposta A.C. 2613 si avvicina al problema, ma non lo affronta fino in fondo.
Il Parlamento avrà ora l’occasione di decidere se fare dell’integrazione il perno del sistema o lasciarla, ancora una volta, sullo sfondo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
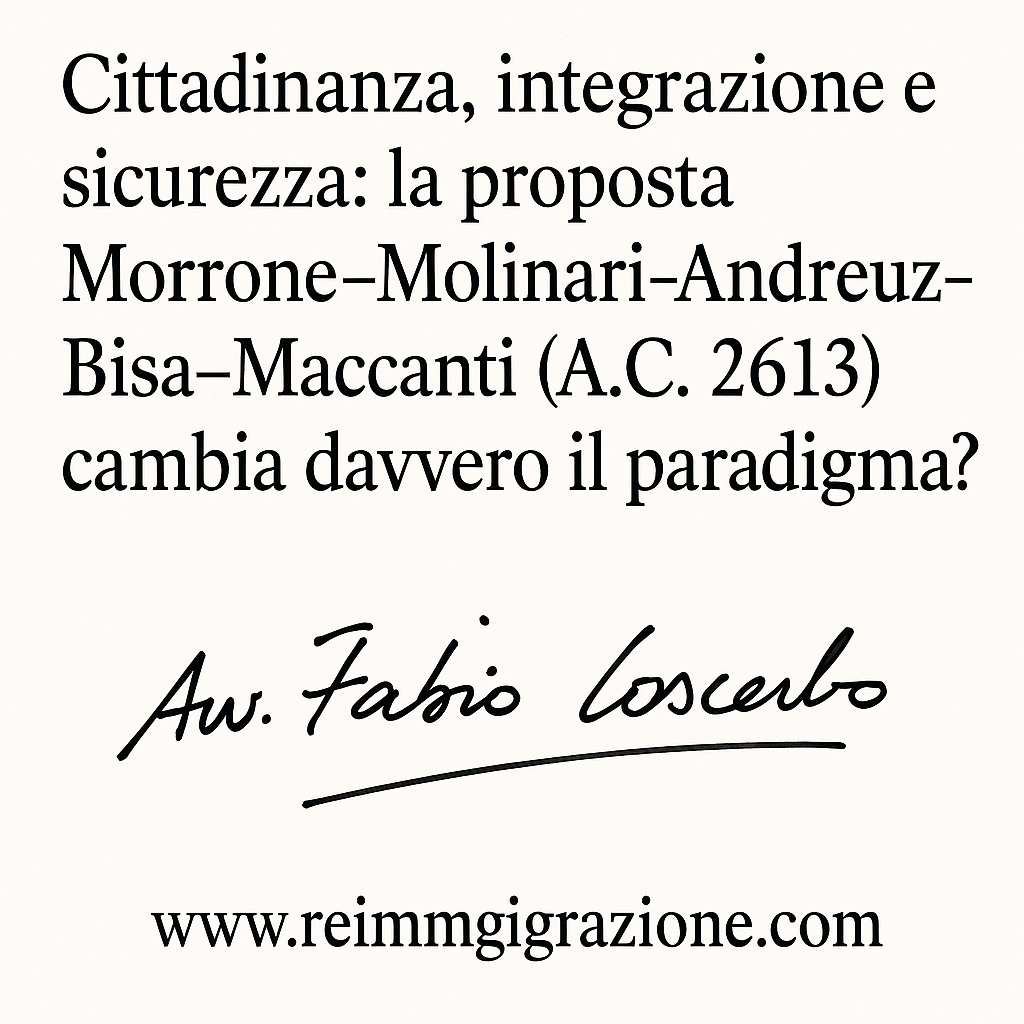
Lascia un commento